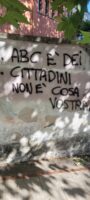Nessun Commento
Nessun Commento IL TEATRO ROMANO DI MINTURNAE RICORDA IL SENATORE MARIO COSTA

 Domenica 6 luglio alle ore 21, il Teatro Romano di Minturnae, giunto al 65 anno di attività, ospiterà una serata speciale dedicata alla sua inaugurazione e in particolare alla figura del senatore Mario Costa, che ebbe l’intuizione di riportarlo alla vita artistica, sottraendolo dall’abbandono di duemila anni. Per farlo ha scelto il maestro Umberto Scipione, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, celebre musicista nato a Gaeta, figlio e nipote di musicisti: suo padre Roberto suonava nell’ Orchestra ritmica della Rai, mentre suo nonno Umberto, da cui il nome, ha fondato il Complesso bandistico “Umberto Scipione Città di Formia”.
Domenica 6 luglio alle ore 21, il Teatro Romano di Minturnae, giunto al 65 anno di attività, ospiterà una serata speciale dedicata alla sua inaugurazione e in particolare alla figura del senatore Mario Costa, che ebbe l’intuizione di riportarlo alla vita artistica, sottraendolo dall’abbandono di duemila anni. Per farlo ha scelto il maestro Umberto Scipione, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, celebre musicista nato a Gaeta, figlio e nipote di musicisti: suo padre Roberto suonava nell’ Orchestra ritmica della Rai, mentre suo nonno Umberto, da cui il nome, ha fondato il Complesso bandistico “Umberto Scipione Città di Formia”.
Ma come rinacque il Teatro romano di Minturnae?
Questa è una breve ma fedele storia di come il Teatro Romano di Minturnae rinacque a nuova vita nell’anno 1960. Chi scrive ha vissuto – poco più che ventenne – tutta la saga di questa rinascita e ritiene di poterne essere fedele cronista, senza aggiunte per esaltare, né dimenticanze per limitare.
Per la precisione questo articolo viene preso da uno scritto per gran parte simile, che venne pubblicato in una bella edizione curata dal Comune di Minturno nel 2005, sotto il titolo Il teatro romano di Minurnae. Le stagioni di spettacoli, dal 1960 al 2004,e contenente una esaustiva silloge di tutti gli avvenimenti.
***
Il Teatro romano di Minturnae non costituisce soltanto uno dei tanti gloriosi monumenti che denunciano, con le terme, le scomparse biblioteche, edifici e templi, il livello di cultura “sociale” dei Romani in terra Aurunca: esso rappresenta un preciso emblema di una struttura civica che, malgrado la difficile storia vissuta, si è perpetuata attraverso i secoli nell’odierna e diversa Città collinare di Minturno, e nelle sue espressioni marittime e interne: Scauri, e Marina di Minturno, Tremensuoli, Santa Maria Infante, Pulcherini e Tufo. La continuità culturale, i cui anelli sono rappresentanti, tra gli altri, da Antonio Sebastiani detto significativamente “Il Minturno”, e, in età più prossima a noi, da Pietro Fedele, ministro della Pubblica Istruzione negli anni Venti del Novecento, Domenico Tambolleo, Angelo De Santis, Cristoforo Sparagna, Pasquale Maffeo, e altri cultori di arti umanistiche e fecondi custodi della tradizione locale, ha avuto il consolidamento materiale nella “resurrezione” del teatro.
Questa risale al periodo compreso tra l’ultimo scorcio degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta del Novecento, quando i ruderi dell’opera, sopravvissuti agli spogli prima dettati dal trasferimento del paese in collina, poi dall’uso come fortificazione fattone dai Saraceni, insediati nell’area del Garigliano nel X secolo, e ivi rimasti fino alla loro dispersione, seguita alla sconfitta inflitta dall’alleanza tra papa Giovanni X e i signori feudali dell’area aurunca nel 915, furono oggetto di interventi di restauro finalizzati alla ripresa delle rappresentazioni.
L’opera di Umanesimo, prima ancora che di archeologia, che sottintende al recupero del teatro nasce dal felice incontro di tre diverse istanze: quella della Soprintendenza archeologica del Lazio, e in particolare del giovane responsabile locale professor Baldàssare Conticello; quella di un altrettanto giovane uomo politico, il dottor Mario Costa, da poco nominato presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo, che lanciò l’idea e sposò il restauro del Teatro con una passione che fu l’arma vincente che superò le difficoltà finanziarie, tecniche, artistiche, burocratiche; e quella di un’ardente passione minturnese che si raccoglieva intorno ai nomi di Angelo De Santis (la guida storica), di Salvatore Signore e di Luigi Raus (presidente e vice presidente della Pro Loco) e di Severino Del Balzo, agli esordi in politica e desideroso di agire, poi divenuto Presidente della Provincia.
Ad essi altri si aggiunsero nel prosieguo: Gennaro Sparagna, Filippo Monti, Pasquale Ferrara, Paolo Graziano, Michele Sparagna, Francesco Rossillo, presidenti della Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo istituita nel 1963.
Accanto ad essi si colloca una schiera di personaggi che, da diverse posizioni di responsabilità, hanno reso possibile il “miracolo” di una continuità artistica che, ormai, ha felicemente girato il Terzo Millennio.
IL “NUOVO” TEATRO
Diventa, perciò, di grande interesse ricordare, a volo d’uccello, i momenti che portarono a fare di un rudere, un centro pulsante di nuova vita teatrale e un prezioso sussidio a quel turismo culturale che è stato costantemente uno degli obiettivi perseguiti dall’Ente Provinciale per il Turismo di Latina. Il concetto di unire la trilogia “spazio monumentale-performance artistica-promozione del turismo” nacque per la prima volta in provincia di Latina sulle rive del Garigliano minturnese. Il problema non era semplice: si trattava innanzitutto di “disseppellire” un’area archeologica e di darle una qualche agibilità; poi si trattava di immettervi in forma non precaria una “istituzione” teatrale capace di fare richiamo. Mario Costa ebbe in quest’ultimo compito il prezioso sussidio di Remigio Paone, grande “guru” del teatro italiano, l’inventore della commedia musicale italiana, il gestore dei più noti teatri di Milano, il futuro Presidente del Maggio Musicale Fiorentino. Paone creò il contatto tra Costa, il regista Ottavio Spadaro, e un personaggio antico d’età e onusto di glorie teatrali, la mitica Emma Gramatica, ill cui quasi compiuto ritiro dalle scene era accompagnato dai continui ripensamenti sulla inopportunità di rinunciare alla sua bravura.
Ed Emma Gramatica, vincendo anche il peso dei molti e gloriosi anni, accettò di tenere a battesimo il rinato Teatro romano di Minturnae, accollandosi il non indifferente onere di interpretare una tragedia che, pur tratta da un grandioso scrittore classico, Euripide, veniva riletta dall’estroso Luciano Raffaele, e presentata sotto il titolo di Le Troadi.
E la rinascita di Minturno fece scalpore in sé, per l’interpretazione della Gramatica e anche per il titolo scelto per la tragedia, che, rinunciando al più tradizionale Troiane, suscitò un dibattito tra colti ,che finì per giovare al lancio del teatro. Era il 1960. Lo spettacolo era nato in anteprima assoluta, per l’organizzazione diretta dell’Ept di Latina. Seguirono in quel primo anno il primo dei diversi Miles gloriosus di Plauto che si sarebbero ripetuti nel prosieguo (ne furono interpreti Arnoldo Foà, Anna Brandimarte, Camillo Pilotto, Giusi Raspani Dandolo, regia di Giulio Pacuvio), e La commedia degli asini, pure di Plauto, con Marco Mariani, Silvio Spaccesi, Paola e Marisa Quattrini.
Prima che Emma Gramatica salisse la scena appositamente allestita, affiancata da Mario Pisu, Miranda Campa, Grazia Marescalchi, Mila Vannucci e dal giovanissimo Astianatte, che era il più che giovane, bambino Maurizio, figlio dell’avvocato Salvatore Signore, per la regia del bravo Ottavio Spadaro, trascorsero giorni di ansie, di fatiche, di preoccupazioni. Si trattava di rendere praticabile al pubblico, agli impianti tecnici, agli attori un’area desueta da millenni, un’area buona per il pascolo delle greggi, per il saccheggio dei primi ladri di reperti, ma non per la cultura.
Fu un miracolo cui collaborarono non molti ma motivati volontari, tra i quali c’era anche chi scrive queste note: sotto il cocente sole di luglio furono sfalciate migliaia di metri quadrati di rigogliose erbe, tracciati passaggi, eretti gabinetti di fortuna, istallato un trasformatore elettrico adattato, creata una piccola area di ristoro.
Ma prima ancora furono svolti i necessari lavori per il parziale restauro delle gradinate, sconquassate dai secoli, divenute cave di materiale edile: sopravvivevano pochi metri di sedili, neppure continui. E fu il primo investimento per un restauro che ha portato il teatro alle attuali dignitose e pressoché complete vesti.
Un primo, grosso investimento seguito, ma quanto faticosamente, da altri: gli interlocutori dell’Ente Provinciale per il Turismo e del Comune di Minturno infatti, usavano rispondere alle richieste di aiuto con una sconsolante formula di stile: “Nonostante ogni migliore intendimento, al momento attuale non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento in merito, in quanto i fondi assegnati per il settore delle opere di interesse storico-archeologico sono stati totalmente impegnati” (così il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno Francesco Coscia, così anche il Ministero della P. I., così l’appena nato Ministero del Turismo).
Eppure il miracolo ci fu: nacque il cantiere, furono avviati i restauri, nacque il teatro. Mario Costa era uomo che conosceva l’arte delle relazioni pubbliche e ancora più la cocciutaggine e l’insistenza e la volontà dell’imprenditore.
Un cantiere, per la verità, che nei primi quindici anni di vita rinacque miracolosamente ad ogni inizio d’estate, perché, terminata la stagione degli spettacoli, tutto ripiombava nell’abbandono, e al giugno successivo l’area archeologica si presentava in condizioni solo un poco diverse da quelle in cui essa apparve nel 1960. Fino a quando l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Minturno-Scauri non divenne adulta e si fortificò, a farsi carico di reinventare annualmente il teatro romano furono i dipendenti dell’Ente Provinciale per il Turismo, che ogni giorno si assoggettavano a faticosi e accaldatissimi viaggi nel primo afoso pomeriggio, si sbracciavano, tagliavano erba, spostavano tavole, piantavano chiodi e avvitavano lampadine, pulivano i gabinetti, ramazzavano le gradinate, poi si improvvisavano bigliettai, controllori, addetti alle latrine e al parcheggio.
Quanta fortuna in quegli anni, che non sia accaduto nulla di dannoso, neppure quando un distrattissimo spettatore, al termine dello spettacolo, per affrettare la sua uscita, non seguì il percorso tracciato, ma tagliò finendo in una buca per la calce (ci rimise solo le scarpe, ma ne seguì una fastidiosissima causa civile); neppure quando una sera, nel pieno dello spettacolo (e le gradinate erano affollatissime) se ne andò la corrente elettrica e non tornò che a mezzanotte. Tutti rimasero al loro posto, nel buio della campagna minturnese, appena rotto dalle lucciole che ancora girovagavano, dal canto dei grilli e dal gracidare delle rane. Cose straordinarie, notti straordinarie, nelle quali chi lavorava al di qua della scena era solidale con chi lavorava sulla scena, quando si stabiliva per ore un rapporto affettuoso e solidale, di reciproca comprensione, tra chi lavorava da una parte e chi assisteva dall’altra. Peppino De Filippo, inappuntabile nel suo completo, malgrado il calore, passeggiava nervoso in attesa che si facesse l’ora; Ernesto Calindri e Gianrico Tedeschi deliziavano e intrattenevano con la loro simpatia; Tino Buazzelli depositava il suo considerevole peso sulle gradinate e faceva circolo raccontando battute e tentando di estinguere la sua inestinguibile sete con casse di acqua minerale.
Gli attori si sobbarcavano a fatiche supplementari: si spogliavano e si truccavano dove capitava, guerreggiavano con le zanzare; poi arrivarono le cabine elettorali trasformate in precari camerini; poi furono creati i primi prefabbricati in legno smontabili, istallato un trasformatore meno capriccioso, avvitate più lampadine e soprattutto più luminose, aperta una seconda entrata (le auto che dall’Appia imboccavano l’unica entrata creavano ingorghi).
Ma laboriosa era la stessa partecipazione degli spettatori, che affrontavano, da autentici pionieri, e impavidamente – gli uomini in giacca e cravatta le donne in abito elegante – torme assetate di zanzare levantisi dal vicino fiume Garigliano, impazzite di fronte allo straordinario, inatteso banchetto che quelle braccia e spalle denudate dalla calura estiva offrivano loro; s’avventuravano fra le sconnesse pietre dell’ambulacro rischiando ogni momento di finire in un canale di scolo per l’acqua piovana: romano, sì, ma pur sempre pericoloso; sostenevano stoicamente l’estrema durezza dei sedili di pietra, fatti per i vigorosi fondoschiena dei Romani, ma assai meno compatibili con la mollezza contemporanea.
Poi, via via, le cose migliorarono, ci fu anche chi affittava cuscini per attenuare il contatto con la pietra, la bouvette divenne una cosa dignitosa, come i gabinetti. E il successo del Teatro romano di Minturnae trascinò con sé altre cose: la riscoperta dei resti del tempio di Marica, l’esigenza di ricostruire il Ponte borbonico sul Garigliano, la necessità di ridare prestigio ai molti monumenti che formano il sostrato antico della cultura minturnese. Il Teatro romano – già affiliato all’Istituto del Dramma Antico – entrò nel circuito degli spettacoli estivi, fu frequentato dalle migliori compagnie di giro, a consolazione di chi l’aveva intuito e faticosamente realizzato. Insieme e oltre ad Euripide, Sofocle, Eschilo, Plauto, Terenzio, Shakespeare, Goldoni sono stati ospitati Stravinskij e Rossini, Ravel e Verdi, in un’alternanza che un tempo faceva storcere il naso ai soprintendenti, ma che ha portato un vasto pubblico alla scoperta di una straordinaria sinergia: quella materiale, fatta di pietre antiche e di luoghi magici, e quella che s’affida alla parola recitata o alla nota che vola nell’aria di una calda notte di mezza estate.
Il teatro, gestito dall’Ente Provinciale per il Turismo di Latina dal 1960 al 1975, venne poi affidato alla giovane e irrobustita Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Paolo Graziano, che lo gestì fino a quando non lo trasferì, a sua volta, al Comune di Minturno.
P.G.S.